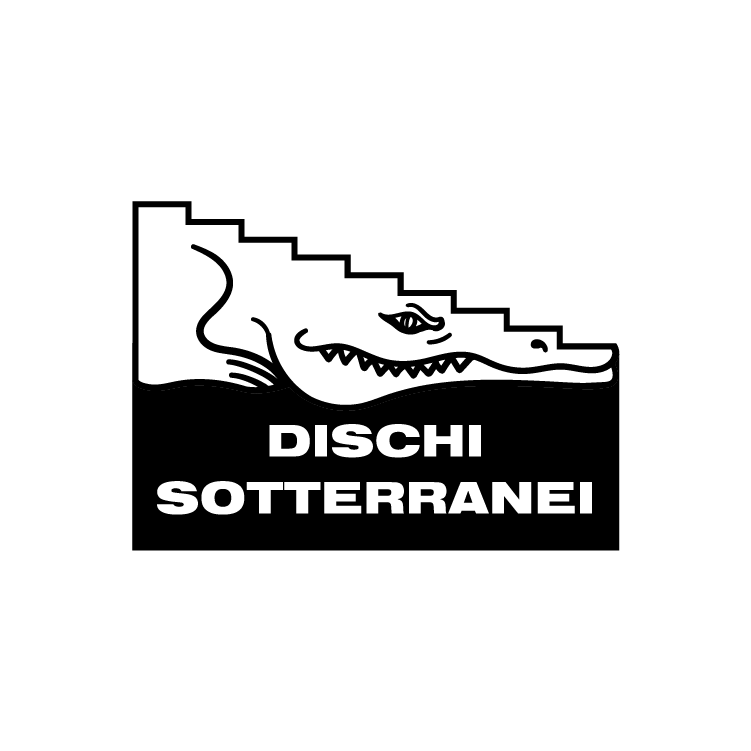Per la definizione stessa del termine sono stato un teenager tra il 1995 e il 2005. In quegli anni, vuoi per le influenze dei nostri fratelli maggiori, vuoi per i canali di consumo disponibili, era molto frequente avere come riferimento culturale e di costume tutto ciò che permeava dalla musica.
Questa viaggiava nell’etere -sino ai tessuti delle nostre menti- costantemente abbinata alle immagini dei videoclip che le maggiori emittenti-tv musicali trasmettevano a nastrone tutto il giorno.
Internet era praticamente inesistente, non tutti ce l’avevano in casa, specialmente se abitavi in mezzo alla campagna. Praticamente non avevi scelta, assorbivi quello che c’era e ti formavi con quello che passava il convento. Ricordo nitidamente il video di 1979 degli Smashing Pumpkins, Buddy Holly dei Weezer, Learn to Fly dei Foo Fighters e poi Intergalactic dei Beastie Boys.
Ricordo Americana degli Offspring tra la prima manciata di dischi che acquistai nelle catene della grande distribuzione, ricordo festival giganteschi con decine di migliaia di sbarbi che saltavano e si sudavano addosso sulle note della, all’epoca celeberrima, colonna sonora di Mission Impossibile. Un’industria enorme con un indotto pazzesco che cominciava dalla TV e coinvolgeva radio, discografia, stampa, cinema ed eventi live. Era totale ed immersivo e tutto ciò creò in noi la voglia di farne parte, o almeno di fare parte di qualcosa, di esprimerci e di somigliare a quella cosa lì. Il dramma è che nessuno ci aveva detto che non si poteva, non ci volevano. Era l’industria a comandare.
Ricordo la prima volta che percepii ciò che per me era il bug del sistema. Intorno al 2000 la sensazione netta che qualcosa stesse sbordando fuori dal vaso.
I Beastie Boys pubblicavano con la loro etichetta discografica “semi-indipendente”, Grand Royal, che tra una miriade di artisti di successo -alcuni di questi anche piuttosto mainstream- firmarono la pubblicazione di un disco che per me cambiò tutte le carte in tavola per sempre: Relationship Of Command degli At The Drive-In.
Il loro videoclip di One-Armed Scissors passava in tv, a orari del cazzo ma passava in tv. Inevitabilmente diventò un successo per una certa fetta di pubblico e per alcuni rappresentò un primo riferimento di contro-cultura che già esisteva da anni ma che per noi sbarbi era inaccessibile ed invisibile.
Fecero un breve tour in Italia accompagnati da una band punk hardcore torinese, gli Encore Fou. Assistemmo ad un loro concerto al Vidia di Cesena e quella notte, in qualche modo, si segnò la fine del nostro rapporto con l’estetica di MTV.
Nel frattempo internet era cresciuto e così fecero anche i movimenti culturali indipendenti. Era più facile accedere alla musica e alla cultura in genere ed inoltre era più facile trovare i tuoi simili e relativi luoghi di aggregazione.
Contestualmente in città, per quello che per me era Bologna, c’era molto fermento soprattutto nell’ambiente punk. Potevi assistere a numerosissimi concerti di artisti internazionali ogni settimana semplicemente spostandoti tra l’XM24 e l’Atlantide e acquistare tra una varietà pressoché illimitata i dischi direttamente dalle distro in loco. Sentii parlare per la prima volta di DIY.
C’era Unhip Records, etichetta indipendente locale, che stava crescendo. Organizzavano rassegne in giro per i circoli e piccoli locali della città, tutto stava diventando una realtà piuttosto tangibile. C’era Underground, un negozietto di dischi in pieno centro, con un catalogo incredibilmente vario e molto specifico. Lì, nel 2005, ci fu una concerto pomeridiano a celebrare una sorta di festa d’anteprima per la pubblicazione di The Plural of The Choir dei Settlefish (Unhip) con apertura degli inglesi Hot Club de Paris. Così, praticamente in mezzo alla strada, del tutto illegale o quasi. Ad una certa arrivarono le forze dell’ordine e si dovette interrompere. Era un momento culturalmente molto florido infatti e, per noi 15-20enni del primo lustro dei 2000, questo contesto e le possibilità che ci dava significavano molto, o meglio, avevamo la sensazione che qualcosa stesse accadendo e per come avevamo percepito la situazione ci sembrava si fosse costituito un filo che connetteva direttamente Bologna a Washington e così per altri poli culturali. Magari ci sbagliavamo ma era bello pensarla così.
Se facevi parte di una band, non era difficile ottenere una base operativa al di fuori dell’Italia o addirittura dall’Europa se quello che ti interessava era fare tour internazionali ed era anche ragionevole pensarlo. Logisticamente era possibile e non era strettamente una questione di opportunità economica in sé, quanto di “giro” e di rapporti che coltivavi.
Esisteva effettivamente un mondo, soprattutto quello legato al punk, in cui le band realizzavano tour piuttosto ampi ed economicamente “onerosi” in maniera del tutto autonoma semplicemente attraverso i rapporti umani, dallo scambio costituito dalle economie di sostentamento di base, alla cooperazione sinergica tra le realtà che lo abitavano.
Alla fine dei conti eravamo ragazzini e di questo mondo ne respiravo soltanto l’aria. Non so se sia una risposta corretta alla domanda “Che cos’è la scena?”, di certo lo è per me. Tuttavia non credo che la costruzione di un identità culturale sia solo un vezzo sociale, piuttosto la risposta più esaustiva alla necessità romantica che hanno tutti di appartenere a qualcosa.
Di Furri Zucchini, Lo Stato Sociale.